|
ALLA FENICE Venezia. Prima e splendida esecuzione a Venezia di "Dafne", un testo ingiustamente misconosciuto del "Teatro della Vecchiaia" di Strauss. Il compositore monacense ritorna a riproporre un tema mitico, ma l'atteggiamento è mutato rispetto ai grandi testi della prima maturità, come "Salome" o "Elettra". Allora c'era una coincidenza tra le scelte linguistiche e alle temperie culturale del tempo, oscillante il liberty velenoso e necrofilo e asprezze pre-espressioniste. Negli anni Trenta invece Strauss approfondisce un atteggiamento quasi estraneo alla storia. Il mito, dunque, sentito come lontananza, e come rifiuto del presente. Composta nel 1937 l'opera evoca, abbastanza fedelmente, il mito celeberrimo di Apollo e Dafne, e Strauss inventa una delle più singolari e sensitive figure femminili del suo teatro, con una "dissoluzione nella natura di bellezza quasi insostenibile" (Zoppelli). L'autore ritorna ad un esplicito wagnerismo o, più esattamente a un classicismo ellenico risentito in chiave post-romantica, attraversato da trasparenze e finezze miniaturistiche.Wagner è visto in controluce e continuamente assottigliato in diafane dolcezze. Sembra quasi che il gusto ornamentale operi una metamorfosi lirica del racconto, adattandolo ad una teatralità evasiva. Apollo, il dio seduttore, ribadisce con ostentazione esplicita il suono del "Tristano", del "Parsifal", del "Sigfrido" ma l'allusione dichiarata si conduce in un'altra area di pensiero: Wagner come necessario punto di riferimento risolto però nell'ornamento sinfonico, che si accende di riverberi e di trasalimenti inconsueti. Così si ripropone il triangolo melodrammatico di una ninfa che si sottrae all'eros, ma che è contesa da due pretendenti antiteci: un dio "dionisiaco", Apollo, e un giovane pastore, Leucippo, prevalentemente apollineo, quasi le due nature simboliche vivessero in una luce intrecciata scambiandosi le parti. Gli artifici decorativi distolgono anche la figura di Gea, la madre di Dafne, dalla sacralità wagneriana e donano un tono più domestico alla citazione di Erda della Tetralogia. La cornice campestre con danze villerecce e prodigi magici - governati dalla provocatoria creatività di Apollo - decade, come altre volte in Strauss, ad effetti senza causa, a pittoresche illustrazioni. Ma è una parentesi transitoria. L'opera ricrea un clima vegetale e arboreo di straordinaria efficacia. Dafne, creatura incontaminata, si specchia nella natura con un sensibilismo affettivo molto emozionante. I suoi due lunghi monologhi, posti strategicamente all'inizio e nell'ultima scena, sono capolavori di cantabilità luminosa e flessibile, mentre l'epilogo con la morte di Leucippo, lancinante e dolorosa e con il rito della metamorfosi di Dafne in lauro, figura tra i culmini del teatro straussiano, in cui trapela una singolare nostalgia per il "Canto della Terra" di Mahler.La bella regia di Paul Curran si giova di una efficace scenografia di Knight: una pedana circolare ruotante che nella seconda parte diviene una struttura multipla, conferendo una forte funzionalità allo spettacolo. La drammaturgia essenziale è ben organizzata, specialmente nella definizione dei tre personaggi principali. Luci efficaci, teatralmente molto calzanti di Jacques. Dirige con prestigio, precisione tecnica e chiarezza cameristica Stephan Anton Reck, puntualmente seguito dall'orchestra e dal coro. June Anderson è magnifica nel largo ruolo di Dafne: esibisce un timbro fulgido e intense curvature melodiche. Autorevole tenore eroico Scott Marc Allister, come Apollo; il ruolo di Leucippo, pensato per un tenore lirico, è sentito in chiave molto drammatica da Roberto Saccà. Elegante l'evanescente contralto Birgit Remmert come Gea e intenso il basso cantabile Daniel Lewis Williams come Peneo. Caldissimo successo per la bella proposta della Fenice. Mario Messinis |
|
OPERA / " Daphne " Daphne non è la prima né l'ultima delle opere composte da Strauss nella condizione di orfano di Hofmannsthal. Appartiene dunque a pieno titolo a quel novero di cimenti cui solitamente si riconoscono (obtorto collo, da parte di qualcuno) gli abili preziosismi e il raffinatissimo esercizio di stile, connessi tuttavia a una staticità drammatica interpretata, in ultima analisi, come segno di sfiducia nello statuto stesso del teatro musicale del tempo. In Daphne, poi, in particolare, i detrattori denunciano tracce di senescenza (nel '38 Strauss era 74enne) come se per spiegare l' interesse al mito bucolico dell'intangibilità, del candore liliale - ché di questo l'opera tratta - fosse necessario indagare l' orizzonte di un uomo che avrebbe rinunciato, volente o nolente, alla sessualità: un po' come avviene nel caso del Wagner di Parsifal. Può essere. Ma guai a dimenticare che Daphne è anche titolo che vanta l'esattezza della sfumatura calligrafica (anche in sede drammaturgica, a dispetto della staticità di cui sopra) e una capacità senza confronti di far coesistere in suprema unità linguaggi musicali diversi: il diatonico di Apollo, il floreale bucolico di Dafne, il cromatico dionisiaco di Leucippo. E non può prescindere da ciò quanto si dice del nuovo allestimento dell'opera prodotto dalla Fenice. Prodotto con merito, non foss' altro che per la scarsissima frequenza con cui ciò avviene in Italia. Per quanto solido, Stefan Anton Reck trascura non poco tali differenze di "registro": privilegia gli aspetti eroici mortificando quelli più suadenti. Governa l'insieme con buona tenuta, sacrificando dettagli importanti. Soprattutto, non convince la fredda messinscena di Paul Curran (considerando anche il Tannhäuser scaligero, si può ben dire un regista sopravvalutato), che sopra un palcoscenico rotante a cerchi concentrici disegna immagini stilizzate, con splendide luci, ma come l'opera fosse un oratorio. Sembra manchino idee, fossero pure ipotesi azzardate. Di alto livello, invece, è il cast, con un' esemplare June Anderson che interpreta con rara intelligenza ogni minima sfumatura della parte eponima, affiancata dagli squillanti Roberto Saccà (Leucippo) e Scott Mac Allister (Apollo). Il teatro non è pieno ma il tributo d'applausi è lusinghiero. Enrico Girardi DAPHNE di Richard Strauss |
|
Arcana, bucolica Daphne In una pagina degli ultimi anni di vita Richard Strauss precisava che se nel campo dell'opera ci sono ancora terre inesplorate da conquistare, un buon materiale di costruzione è già predisposto in quel 'viale delle sfingi' grecizzante e personalissimo che ha "donato all'umanità simboli musicali che possono essere considerati la realizzazione finale di ciò a cui i greci aspiravano". Il compositore si riferiva ad Elektra, Elena Egizia e a Daphne che, con variabili temperature musicali, sfruttano il declamato a mutevoli distanze dall'arioso. Terminata in terra solare, nel 1937 a Taormina, dopo una genesi complessa, la "tragedia bucolica con balli e cori" di Daphne si avvale di un plot metamorfico psicologizzato e di misteriosa interiorità: il simbolo del flauto e delle gote di Leucippo, Apollo nelle vesti di bovaro eppure con tutti i segni della sua forza omerica, il travestimento di Leucippo nel corso della festa dionisiaca, il canto funerario di Daphne e la sua trasformazione. Kleistiano, cupo e soffocante di mistero, il mito della vergine-ninfa Daphne (cui si erano appellati nel 1598, agli albori del teatro per musica, Rinuccini e Peri) si dibatte tra la venerazione per Apollo e l'amore fraterno per l'amico di gioventù. La diversa interpretazione da parte di Strauss dell'antico mito fece maturare nel teatrologo Gregor una terza e definitiva stesura del libretto alla quale partecipò anche Stefan Zweig e molti suggerimenti vennero anche da Clemens Krauss. Alla fine, dopo aver tolto il prolisso finale di Gregor, con tanto di forze corali, il compositore disse al librettista: "via tutto ciò che è di disturbo! Soltanto l'albero canta!" Parte proprio dall'albero la scena iniziale pensata da Kevin Knight per questa Daphne lagunare (mai rappresentata prima d'ora alla Fenice): un albero stecchito posto su una scena unica nera, una piattaforma tonda a cerchi concentrici che nel corso dell'atto unico più volte si alza e si abbassa roteando a spirale e inghiottendo nel vortice della tragedia in dissolvenza i miti, abbigliati in una varia e colorata galleria balcanica (serbo-montenegrina, macedone, derviscia, ecc.) più folclorica che pertinente al tema, tanto da sottrarre fascino all'aura mitica dell'ambientazione pastorale. La regia di Curran ha dimostrato chiarezza ed esatta misura, esaltando la protagonista, June Anderson, superlativa nei monologhi e nella scena di chiusa "muta", emozionante, una immagine di desolazione concepita come un viatico nell'interiorità. Meritano elogi anche Saccà, MacAllister, Lewis Williams e le bronzee doti contraltili della Remmert. Bravi anche gli artisti di fianco e le danzatrici. Stefan Anton Reck ha tracciato una esecuzione di impressionante tensione speculativa, esaltando il retroterra storico della tradizione tardo-romantica e mirando nel contempo a un raffreddamento novecentesco della materia sonora, senza rinunciare agli appelli cantabili e alle drammatiche tensioni in cui il discorso musicale si configura come una maestosa cosmogonia fonica. Pubblico festoso ed entusiasta. Maria GIRARDI |
|
Opera. June Anderson ottima interprete del lavoro, per la prima volta a Venezia di Cesare Galla
In questa versione del mito, allora (i versi sono di Joseph Gregor, ma lo stesso musicista influì ampiamente sul testo), una dialettica e complessa polarità fra apollineo e dionisiaco allarga decisamente, e con sincretistica sovrapposizione di spunti, il tema originale della vicenda metamorfica. Non è infatti più solo questione, qui, di un racconto nel quale la ninfa concupita da Apollo viene pietosamente sottratta alle sue brame trasformandosi nell’alloro. La storia freme di motivi ben diversamente complessi, estrinseca un senso panico della natura che trova nel culto dionisiaco del tralcio fiorito il momento nel quale le pulsioni sessuali trovano una motivazione rituale possente e alla quale è impossibile sottrarsi. A queste pulsioni, a questa ritualità, Dafne è però sostanzialmente, profondamente estranea. Essa vive una sorta di simbiotica fratellanza con gli elementi naturali, e specialmente con la luce e con la vegetazione (i due poli del suo destino), ma tende disperatamente a sottrarsi alle inesorabili conseguenze di questa appartenenza, rifugiandosi in una concezione di rarefatte corrispondenze psicologiche. Estranea al tempo e alla storia, intesa come inevitabile attuazione delle pulsioni naturali, essa vive dunque una condizione implicitamente tragica. Non molto diverso doveva essere l’atteggiamento di Richard Strauss negli anni in cui il nazismo, dopo avere conquistato il potere, iniziava la folle marcia che si sarebbe conclusa solo nella catastrofe totale. Capolavoro misconosciuto e di rara presenza nelle locandine, la Daphne ha visto l’altra sera la sua prima rappresentazione a Venezia, terza gemma (dopo Capriccio e Ariadne auf Naxos) della corona straussiana che i programmi della Fenice stanno costruendo dal 2002, iniziativa fra le più interessanti e meritevoli di attenzione dal punto di vista musicale e culturale in questi ultimi anni. L’allestimento recava la firma di Paul Curran (scene e costumi di Kevin Knight), che ha scelto la strada di una figuratività insieme astratta e allusiva, di pittorica evidenza, costruita su pochi elementi scenici e su costumi di suggestione orientale (quasi a indicare le radici dei culti dionisiaci). Una grande piattaforma circolare, ad anelli scomponibili e variamente capaci di movimento anche in verticale, è il simbolico contesto naturale del racconto, per il resto animato da una superba caratterizzazione luminotecnica (David Jacques) essenziale per creare le magnifiche "foreste di luce" in cui tutta la vicenda sembra immersa, come anche per dare il senso del soprannaturale che fa irruzione nella storia con l’arrivo di Apollo. La raffinata sottigliezza nella recitazione completa uno spettacolo avvincente, esemplare, che alla prima è stato salutato da vere ovazioni anche per merito della resa musicale. Dal podio, Stefan Anton Reck percorre con instancabile attenzione la complessa trama della scrittura straussiana, delineando le atmosfere timbriche con la lucida precisione dei disegni "Art-nouveau" straussiani, e non lesinando in "peso" e densità quando la vicenda evolve verso le sue regioni più oscure, psicologicamente, e wagneriane, musicalmente. Nel cast spiccava il nome di June Anderson, regina del belcanto in una non recente stagione: ammirevole ancor oggi per la musicalità e la pienezza stilisticamente impeccabile della linea di canto, a delineare una Dafne trasognata e introversa, ripiegata su se stessa eppure capace di slanci ingenui quanto inebrianti. Al suo fianco, nei due complessi ruoli tenorili, Roberto Saccà e Scott Mac Allister. Il primo è stato un Leucippo vibrante di estroversa cantabilità, il secondo un Apollo di wagneriana baldanza, capace di salire facilmente all’acuto pur pagando pegno alla ricchezza del colore, e con qualche forse inevitabile affaticamento alla fine. Autorevoli Daniel Lewis Williams e Birgit Remmert (Peneo e Gea), ammiccanti e suadenti le ancelle Liesl Odenweller e Dorothee Wiedmann. Si replica domani pomeriggio (15.30) e poi il 15, 18 e 21 giugno. Chi ama cercare i multiformi segni della modernità nella cultura del primo Novecento, non dovrebbe lasciarsi sfuggire l’occasione. |
|
Venezia, Teatro La Fenice Daphne "Daphne", tragedia bucolica in un atto, terz'ultima composizione operistica di Richard Strauss, fu rappresentata a Dresda nel 1938, alla fine di un laborioso percorso compositivo, iniziato nel 1936. Alla luce dei fatti, nonostante il successo della prima, l'opera straussiana, ispirata al mito della ninfa Dafne che viene da Zeus tramutata in alloro per salvarla dalle brame di Apollo, risulta tra le più deboli tra quelle del grande Bavarese. Strauss sembra aver esaurito la sua vena drammaturgica e in "Daphne" diventa marcatamente autoreferenziale, citandosi in continuazione e producendo un' opera che ritorna continuamente su se stessa, fatto salvo il magnifico, intensissimo e geniale finale sinfonico, questo sì veramente nuovo, nel quale la Ninfa si trasforma in pianta. Per il resto "Daphne" ci è sembrata un'"Ariadne" in sedicesimo, la musica è piacevole, ben scritta, ma nulla più. Tra le pagine "ispirate", oltre al già citato finale, corre l'obbligo di ricordare la scena in cui il pastore Leukippos, innamorato di Daphne, viene convinto dalle di lei ancelle a travestirsi con gli abiti di Daphne stessa per recarsi alla festa dionisiaca, scena che rimanda a quella di Parsifal circondato dalle Fanciulle Fiore, se non anche alle Figlie del reno che scherniscono Alberich. A parziale difesa di Strauss, che comunque compone con la maestria che gli sarà propria sino alla morte, e che ritroveremo intatta anche nell'ispirazione nelle "Metamorphosen" e negli struggenti "Vier letzte Lieder", dobbiamo ricordare che egli ebbe a disposizione un libretto di rara inconsistenza, scritto da Joseph Gregor, al quale difettava non solo il genio di Hofmanstahl, ma anche più semplicemente il grande mestiere di Stephan Zweig, libretto cui lo stesso Strauss dovette rimettere mano più volte anche solo per cercare di ottenere il taglio che egli richiedeva per la sua "Daphne". Gregor non comprese appieno il desiderio d Strauss, il quale voleva che fosse lampante la contrapposizione tra amore spirituale ed amore sensuale, tratteggiando alla fine una protagonista fredda ed impaurita sia dall'amore carnale che le offre Leukippos che da quello solare e trasfigurato di Apollo. Se la musica ci ha lasciati francamente perplessi, l'allestimento dell' opera, che viene in quest'occasione rappresentata a Venezia per la prima volta, ci ha convinti appieno sia dal punto di vista musicale che sul versante dell'allesimento. Il giovane regista scozzese Paul Curran firma uno spettacolo assai elegante, nel quale prevalgono movimenti sobri, quasi di danza accennata, i quali offrono una convincente caratterizzazione dei personaggi. Grandissima cura agli sguardi, alle mani, alle posizioni delle braccia. Molto bella la scena della festa dionisiaca, con maschere arcaiche e danzatori "dervisci", che ben rapperesentano l'estasi erotica. Suggestiva nella sua semplicità la scena di Kevin Knight, che firma anche gli eleganti costumi atemporali, costituita da una pedana circolare, i cui cerchi concentrici in cui è divisa si inclinanano muovendosi attorno ai personaggi e creando, grazie anche ad un sapiente light-design, atmosfere assolutamente coinvolgenti. Benissimo l'aspetto musicale. Stefan Anton Reck concerta con mano sicura e convincente, assecondato da un orchestra in ottima serata. La sua lettura estetizzante, ma mai stucchevole, è del tutto appropriata allo spirito dell'opera, che Reck ci è parso avere colto appieno. Splendida la Daphne di June Anderson, al debutto nel ruolo, la quale quale vive un periodo vocalmente felicissimo. La voce è bella, sicura in acuto, suadente nei centri, perfetta nelle agilità emessa senza sforzo alcuno, una vera gioia per le orecchie; a questo si deve aggiungere una totale aderenza al personaggio. La definizione più bella della cantante statunitense l'ha data proprio il regista, riferendosi all'intesa artistica creatasi nel corso delle prove, affermando che lavorare con la Anderson "è come tagliare una stoffa pregiata". Per lei una vera ovazione al termine. Molto bene anche Roberto Saccà, che ha cantato il suo ardente Leukippos con voce calda e con accenti convincenti, senza mai forzare e sempre attento alla recitazione e che ci ha convinto assai più qui che non nella Traviata inaugurale. Interessante l'Apollo di Scott Mac Allister, tenore dotato di bella voce, ben proiettata soprattutto nel registro acuto. Mac Allister rende assai bene la nobile "solarità" del personaggio ed ottiene un buon successo, "sporcato" dall' unico "buuu" di un imbecille in seconda galleria. Più che a posto le parti di contorno, sulle quali spiccano il buon Peneios di Daniel Lewis Williams e la Gaea di Birgit Remmert, contralto dai gravi poderosi. Bene gli altri comprimari, ancelle e pastori. A posto anche il coro, istruito da Emanuela Di Pietro, che si è ben comportato nei suoi brevi interventi. Alla fine grande successo da parte di un pubblico attentissimo. Alessandro Cammarano |

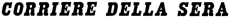


 Uno dei miti classici più radicati e fervidi di conseguenze creative nella cultura dell’Occidente diventa con Richard Strauss, negli anni che precedono la seconda guerra mondiale, occasione di una singolare e originale rivisitazione. La sua Daphne (Dresda, direttore Karl Böhm, 1938) si propone infatti da un lato come una sorta di sintesi delle varie istanze filologico-culturali con cui il mondo antico e le sue storie venivano analizzati dalla modernità, dall’altro come il "terreno" in cui far agire (e diventare elemento drammaturgico) una sottigliezza psicologica di particolare portata allusiva.
Uno dei miti classici più radicati e fervidi di conseguenze creative nella cultura dell’Occidente diventa con Richard Strauss, negli anni che precedono la seconda guerra mondiale, occasione di una singolare e originale rivisitazione. La sua Daphne (Dresda, direttore Karl Böhm, 1938) si propone infatti da un lato come una sorta di sintesi delle varie istanze filologico-culturali con cui il mondo antico e le sue storie venivano analizzati dalla modernità, dall’altro come il "terreno" in cui far agire (e diventare elemento drammaturgico) una sottigliezza psicologica di particolare portata allusiva.